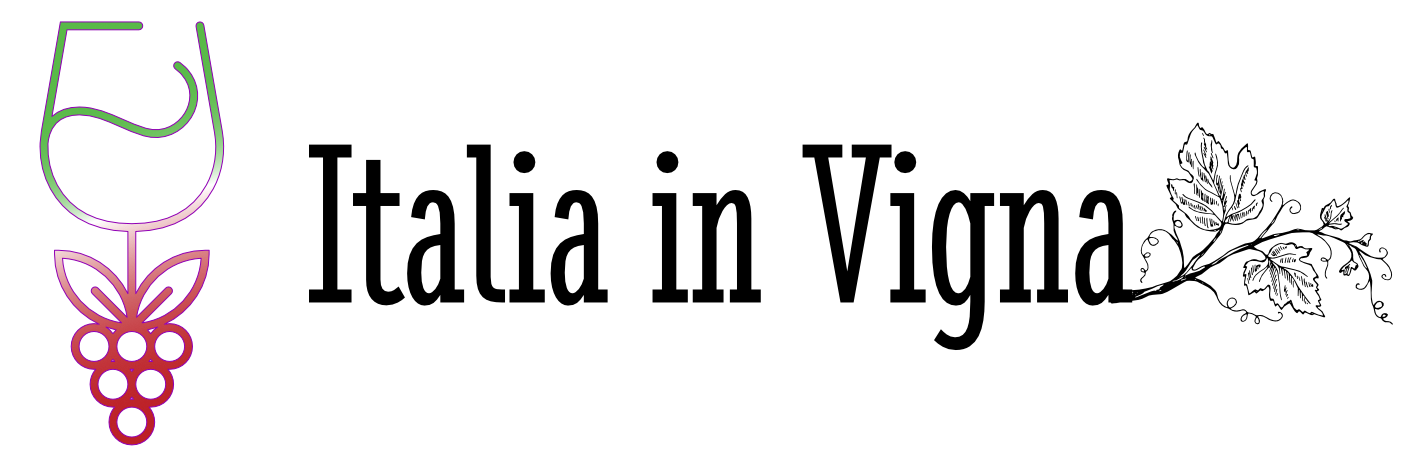Brescia e il vino.
Un forte legame, basato innanzitutto sulle potenzialità dell’ambiente, dato che gli elementi naturali come clima, terreni e quant’altro, risultano assai favorevoli alla vitivinicoltura.
In effetti, se osserviamo il territorio che circonda la città e che si sviluppa per l’intera ed ampia provincia, troviamo un paesaggio eterogeneo ma caratterizzato spesso dai vigneti, dalle diverse dimensioni e che determinano le quattro zone bresciane d’interesse enologico:
Franciacorta, Riviera del Garda, Colli dei Longobardi e Valle Camonica.
Da alcuni anni in tutta quest’area si è sviluppato, in modo rilevante, l’enoturismo.
Laghi, montagne, colline e verdi piane, ma non solo, perché è un territorio ricco di piccoli borghi, abbazie e ville storiche, attraversato anche da veri e propri percorsi naturalistici, dal nome le “Strade del vino” con moltissime cantine da visitare, nelle quali fare interessanti degustazioni e acquistare eccellenti bottiglie; in zona poi, c’è una vasta gamma di strutture per pernottare e per qualsiasi tipologia di turista.
Ma nel bresciano non c’è solo la natura idonea alla vite, c’è un’antica tradizione.
Si passa dai fossili di vinacciolo della “vitis silvestris” nelle colline adiacenti la città di Brescia o della “vinifera sativa” nei pressi della riviera gardesana, fino ai vari oggetti risalenti l’epoca romana e ritrovati negli scavi in diverse zone della provincia.
A Brescia, in prossimità del centro storico, c’è un piccolo colle dal nome Cidneo, sulle cui pendici c’è il più ampio vigneto cittadino d’Europa, dal nome “Pusterla” con più di 3 ettari di superficie, dal quale si suppone che fin dal lontano XIII secolo si ottenesse del vino, che in parte veniva consumato alla mensa dello splendido Monastero di Santa Giulia (sito UNESCO) situato ai piedi del colle.
E’ ancora oggi una vigna in produzione e rappresenta un panorama assai attraente, perché il vigneto è sovrastato da un antico castello riedificato nominato il “Falcone d’Italia”.

Infine, i documenti, le illustrazioni e gli scritti d’epoca recuperati nel corso dei secoli, hanno dimostrato quanto antica sia la vitivinicoltura in questa provincia soprattutto in Franciacorta e lungo le colline moreniche del Garda, zone che attualmente sono tra le più rinomate anche al di fuori dei confini italiani.
Oggi la provincia bresciana è la seconda produttrice di vini in Lombardia, con una DOCG, una decina di DOC e alcune IGT, a dimostrazione del livello qualitativo dei vini prodotti.
I Colli dei Longobardi è una delle zone a forte interesse enologico, un percorso turistico ed enogastronomico che parte da Brescia, dal vigneto “Pusterla” e prosegue nella zona pedemontana delle Prealpi bresciane, per finire a sud-est nella piana verso le province di Mantova e Cremona.
Area di antica vocazione vitivinicola, con i galli prima, i romani poi e successivamente i longobardi che con re Desiderio, nativo di Brescia, lasciarono anche un’impronta culturale alquanto significativa.
All’interno di questa zona, nelle vicinanze del capoluogo, troviamo il comune di Botticino, costituito da tre frazioni distribuite in una valle dal nome “Valverde”, che rappresenta la zona di produzione del Botticino DOC, una denominazione tra le più antiche d’Italia, visto che è stata istituita nel 1968.
Questa DOC prevede un uvaggio di uve nazionali, quali Barbera 30%, Marzemino 20%, Sangiovese 10% e Schiava Gentile 10% e contempla due tipologie vinicole, Rosso e Rosso Riserva, che differiscono per il periodo d’invecchiamento in botti, 24 mesi per la seconda.
Il nome di questo comune sembra derivi da “bott’ de’ vì” (botte di vino) per il chiaro legame con la vitivinicoltura, oppure in ricordo del primo proprietario delle famose cave di marmo qui presenti.
In effetti, questa piccola area è conosciuta nel mondo per il marmo estratto da questi colli e usato per la costruzione di molti famosi edifici o monumenti, come ad esempio la Casa Bianca, l’Altare della Patria a Roma e per gli interni della stazione centrale di New York.
Da alcuni anni anche il vino ha giocato un ruolo importante nel contesto socioeconomico locale, espresso anche dal forte legame con l’ambiente naturale.
Infatti, il suolo argilloso, calcareo e ricco di minerali (marnoso), risulta ideale per la coltivazione delle vigne, le quali esposte da nord a sud godono di un’ottima insolazione e risultano protette dalle Prealpi.
Inoltre, il clima è favorevole, caratterizzato da una brezza leggera e sempre costante, da una buona escursione termica giornaliera e da una stagione invernale non particolarmente rigida;
l’habitat perfetto per definire il carattere di un vino e ottenere ottimi risultati produttivi.
Quelli che negli ultimi anni hanno ottenuto alcune cantine della zona ed una in particolare, la Cantina Noventa, chiara espressione aziendale di questo difficile territorio.
In effetti, in questa zona la viticoltura è per lo più “eroica”, per la conformazione di questi colli, dove le viti sono allevate sui terrazzamenti e ancora oggi le lavorazioni meccaniche sono alquanto limitate.
La conduzione di quest’azienda è da sempre e da decenni familiare, undici ettari con le vigne distribuite a 380 mt di quota, curate con grande attenzione, con metodi tradizionali e biologici, per l’amore verso la propria terra e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Questa cantina produce tre “cru”, uno per ogni collina, ognuna con piante di età diversa, e tra questi c’è un eccellente Botticino DOC (3 bicchieri Gambero Rosso 2022) “Gobbio 2018”, ottenuto con uve come da disciplinare e che deve il suo nome al colle dal profilo gibboso dove è situato il vigneto.
Le uve giunte a maturazione vengono vendemmiate e accuratamente diraspate e di seguito, immesse in botti di legno per due settimane per la relativa fermentazione, durante la quale vengono eseguite follature e rimontaggi manuali.
Successivamente il tutto viene trasferito in botti di legno di medie dimensioni per 18 mesi, per la sua evoluzione. Imbottigliamento finale con affinamento per 6 mesi.
Nel bicchiere si presenta di un bel colore rosso rubino carico. Fruttato, floreale e speziato. Prugna, lampone e ciliegia in confettura. Fiori di campo ed erbe aromatiche con una delicata spezia finale.
Corposo, morbido e strutturato, caldo e dal giusto tannino, acidità e grande mineralità; buona persistenza. Gradazione alcolica 15%.
Da bere subito ma si può invecchiare anche per una decina d’anni.
La temperatura di servizio è di 16-18°C e dopo averlo aperto per la giusta ossigenazione, abbiniamolo ai piatti di carne: grigliate miste, arrosti di carne rossa. Bolliti, carré di maiale e faraona al forno o manzo di Rovato all’olio. Primi piatti forti, con ragù di carne o selvaggina, oppure taglieri di salumi e formaggi stagionati.
Molti lo abbinano giustamente al piatto tipico bresciano per eccellenza, lo spiedo con polenta e patate.
E naturalmente
…mezzo vuoto o mezzo pieno??
Purchè sia buono, bianco, rosso e verde!!